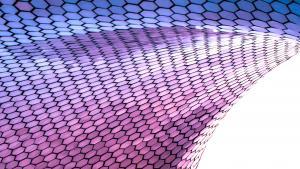L’inchiesta sul caporalato nella moda prosegue ma con una svolta giudiziaria senza precedenti, un vero e proprio salto di livello.
Il 4 dicembre 2025 la Procura di Milano ha richiesto formalmente a 13 grandi marchi del lusso — tra cui Prada, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas Italia e Off-White — la consegna di un vasto insieme di documentazione interna: organigrammi, contratti con i fornitori, audit eseguiti, report di tracciabilità, modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari, controlli di filiera.
Non sono state emesse accuse. Non è stato disposto alcun commissariamento. Non ci sono misure cautelari.
Fino a qualche settimana fa l’approccio era diverso. Quando gli inquirenti individuavano uno sfruttamento sistemico (laboratori clandestini, turni massacranti, salari irregolari, dormitori abusivi) intervenivano in modo diretto e immediato con sequestri, arresti e, nei casi più gravi, amministrazioni giudiziarie applicate a marchi noti.
Questa volta no. Questa volta il meccanismo è più sottile, più chirurgico, più strategico.
Un segnale, il più forte che la magistratura abbia mai lanciato al settore con una svolta di metodo: non più repressione, ma un’analisi strutturale.
Le autorità entrano nella filiera senza incriminare, ma pretendendo trasparenza assoluta.
È un invito a “mostrare le carte” e, allo stesso tempo, un avvertimento: se i controlli non sono credibili, se i fornitori non sono tracciati, se la governance non presidia la filiera, allora la responsabilità sarà del brand.
Chi la definisce una “fase soft” commette un grave errore
A leggere autorevoli quotidiani trapela una errata e diffusa convinzione: questa nuova linea adottata dai magistrati milanesi appare “più leggera”.
In realtà non lo è affatto, è un’indagine strutturata di secondo livello. Non usa lo strumento duro del commissariamento, ma produce un effetto analogo e, in prospettiva, più dirompente.
“Mostratemi che non potevate saperlo. Se non riuscite a dimostrarlo, procediamo.”
Non è affatto soft, è un invito formale a dimostrare l’innocenza organizzativa.
Dalla linea dura alla linea più ampia
L’indagine non è più “potenziale”, si sta scavando per ricostruire l’intera catena produttiva opaca, un controllo sistemico sull’intera industria del lusso in Italia. La richiesta formale di documenti significa che gli investigatori stanno preparando il terreno per possibili provvedimenti più gravi con un focus su trasparenza, governance e compliance.
La fase è documentale, ma non è affatto interlocutoria: rappresenta una due diligence giudiziaria sulla catena del valore, condotta con gli stessi criteri usati dagli inquirenti nei casi più complessi. È la prosecuzione di un percorso iniziato da qualche anno e che aveva portato a provvedimenti ad hoc per il brand coinvolto.
Da allora il tema non riguarda più “qualche caso isolato”, ma un’intera architettura produttiva da ripensare. Il punto non è più il singolo caso perchè, ormai sembra acclarato, questo schema è ormai ricorrente.
E il settore non può più considerarlo un'anomalia tantomeno non può più non essere ritenuto responsabile della propria filiera.
Cosa significa per il settore moda
In un mercato che vive di immagine, qualità e reputazione, la trasparenza della supply chain non è più un’opzione: è un vantaggio competitivo e un requisito di compliance.
Oggi, per un brand, il rischio reputazionale è più pericoloso del rischio penale. I media internazionali pubblicano la notizia prima ancora che la Procura formuli un’ipotesi di reato. I consumatori leggono i titoli, non le sentenze. Gli investitori reagiscono alle percezioni, non alle carte processuali.
E c’è un elemento che i brand troppo spesso sottovalutano: la reputazione non si difende con la comunicazione, ma con il controllo, la trasparenza e la prevenzione tecnica.
Oggi i brand rischiano di essere travolti da una crisi reputazionale prima ancora che legale.
Da dove iniziare
Per chi opera nel settore moda, oggi ci sono due strade: aspettare, o mettersi al sicuro. Le contromisure concrete:
- Implementare un modello di governance e controllo interno realmente efficace: non basta un codice etico, servono organigrammi chiari, attività di monitoraggio concreto, audit indipendenti e ricorrenti.
- Tracciare e certificare tutta la filiera, fino all’ultimo subappalto: contratti trasparenti, tracciabilità dei fornitori, reportistica, visite a sorpresa, censimento dei fornitori di primo e secondo livello.
- Effettuare stress test 231 sulla supply-chain, ovvero simulare un’ispezione reale.
- Essere pronti a trasparenza totale: dati, report, audit, contratti, esiti. Meglio arrivare con le carte in regola che con le “buone intenzioni”.
Il nodo centrale della vicenda
La nuova inchiesta non dice che i grandi marchi sono colpevoli. Dice qualcosa di più profondo: la filiera del lusso deve cambiare radicalmente perché è diventata troppo vulnerabile, troppo frammentata, troppo opaca per sostenere lo standard etico che i marchi dichiarano.
Il vero esame che attende le aziende non è quello penale. È quello della credibilità.
La domanda che ogni brand dovrebbe porsi oggi è semplice, brutale e inevitabile: “Se domani la Procura bussasse alla nostra porta, saremmo in grado di dimostrare che la nostra filiera è sotto controllo?”